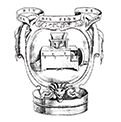Sala del Vocabolario
Il primo Vocabolario
Intorno al 1590 l’attività dell’Accademia iniziò ad essere concentrata nella preparazione del Vocabolario. I criteri di scelta degli autori citati vennero stabiliti in vista del fine che i vocabolaristi si proponevano: mostrare e conservare la bellezza e l’utilità del fiorentino trecentesco. Le prime opere oggetto di spoglio furono la Commedia di Dante, il Decameron di Boccaccio e il Canzoniere di Petrarca.
La maggior parte degli spogli interessò testi, non solo letterari, fiorentini del Trecento, ma non mancarono aperture verso autori successivi (tra i quali Lorenzo de’ Medici, Berni, Machiavelli, Salviati stesso) e verso autori non fiorentini (Bembo, Ariosto). Furono affrontate anche questioni di metodo, in particolar modo sul trattamento delle voci dell’uso, di cui non si trovassero attestazioni antiche, e sul problema dell’inserimento delle etimologie: per le prime si stabilì di allegare esempi tratti da autori moderni fino a Monsignor della Casa, per le etimologie venne data l’indicazione di considerare solo quelle “che abbiano gentilezza e sieno a proposito”; in tutti e due i casi si rimandava comunque al giudizio dei Deputati per il Vocabolario, una commissione di quattro accademici – Carlo Macinghi, Francesco Marinozzi, Piero Segni e Francesco Sanleolini – nominati nel 1597 proprio per affrettare e facilitare il lavoro di redazione del Vocabolario.
Anche nella compilazione furono seguiti gli stessi criteri, per cui gli scrittori fiorentini del Trecento vennero citati per primi, dove era possibile con un esempio di prosa e uno di poesia. Dei non fiorentini si scelsero le parole più belle e di matrice fiorentina, dei contemporanei le voci dell’uso.
Il Vocabolario degli Accademici della Crusca fu stampato a Venezia e uscì nel 1612, suscitando immediatamente grande interesse e altrettanto accese dispute riguardo ai criteri adottati; in particolare, a molti non piacque l’aperto fiorentinismo arcaizzante proposto dal Vocabolario, che comunque rappresentò per secoli, in un’Italia politicamente e linguisticamente divisa, il più prezioso e ricco tesoro della lingua comune, il più forte legame interno alla comunità italiana, quindi lo strumento indispensabile per tutti coloro che volevano scrivere in buon italiano.
Ebbe grande fortuna in tutta Europa e divenne modello di metodo lessicografico per le altre accademie europee nella redazione dei vocabolari delle rispettive lingue nazionali.
La seconda edizione
La seconda edizione del Vocabolario fu pubblicata nel 1623, sempre a Venezia, a cura di Bastiano de’ Rossi. Rispetto alla prima non ci furono modifiche o aggiunte di grande rilievo. Le dimensioni del vocabolario rimasero le stesse (sempre un unico volume) anche se vennero inseriti tra le opere citate le Rime di Michelangelo, le Lettere del Tolomei, le poesie del Guarino, i Beoni di Lorenzo de’ Medici, le opere di Ludovico Martelli, il Demetrio del Segni e le rime burlesche di Luca Martini.
La terza edizione
La terza edizione, uscita nel 1691 e per la prima volta stampata a Firenze (le prime due edizioni furono stampate a Venezia) con dedica a Cosimo III de’ Medici, costituisce, sotto diversi punti di vista, un’opera non solo accresciuta quantitativamente (tre volumi), ma anche rinnovata qualitativamente: alla sua lunga compilazione (i lavori iniziarono nel 1648) parteciparono anche uomini di scienza come Francesco Redi e Lorenzo Magalotti. Leopoldo de’ Medici, fondatore dell’Accademia del Cimento e protettore dell'Accademia della Crusca, dette il suo personale contributo raccogliendo termini tecnici di arti e mestieri che, per la prima volta, faranno la loro timida apparizione tra le voci del Vocabolario insieme agli astratti verbali, ai diminutivi, ai superlativi e agli accrescitivi. Per questa edizione furono spogliati una cinquantina di autori antichi e altrettanti moderni tra cui il Tasso, il Segneri, il Pallavicino, sempre citati in mancanza di attestazioni antiche o per dimostrare l’effettivo uso di una parola.
Durante i lavori di preparazione della terza impressione un altro importante progetto, non andato a buon fine, fu intrapreso dal Dati: la messa a punto di un dizionario etimologico della lingua italiana che avrebbe dovuto concorrere al progetto degli Accademici di fornire nuovi strumenti linguistici modellati sulla tradizione letteraria fiorentina. Per quest’opera furono preparate molte schede con la collaborazione anche del Redi, ma presto fu evidente che il progetto della Crusca non era destinato alla riuscita perché preceduto dalla pubblicazione, tra il 1666 e il 1669, delle Origini della lingua italiana del francese Gilles Ménage. Allora molto del materiale raccolto fu mandato a Parigi, dove Ménage poté avvalersene; in particolare arrivarono le etimologie redatte dal Redi che riguardavano principalmente la terminologia di medici e speziali, secondo gli interessi e le competenze specifiche dell’autore.
La quarta edizione
La quarta edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca apparve in Firenze, stampata da Domenico Maria Manni in sei volumi, dal 1729 al 1738 e dedicata a Gian Gastone de' Medici. Era stata iniziata già nel 1696 e vi lavorarono in molti tra cui il Salvini, il Bottari che ne scrisse la prefazione, Rosso Antonio Martini, Andrea Alamanni. Fu ampliata la serie dei citati con Sannazaro, Cellini, Menzini, Lorenzo Lippi e molti altri; furono date più rigorose norme per gli spogli, in particolare vennero controllate le citazioni che erano state prese da testi a penna o da edizioni ritenute non corrette. Anche questa edizione non mancò di provocare discussioni e critiche e, anche per soddisfare le richieste del pubblico, lo stesso Manni nel 1739 compendiò il Vocabolario che vide tre ristampe private: due a Venezia (a cura di Francesco Pitteri nel 1741 e nel 1763) e una a Napoli (a cura di Pasquale Tomasi nel 1746) con alcune aggiunte. Le critiche più aspre riguardavano la pretesa della Crusca di volersi arrogare il diritto di legiferare in materia di lingua e di canonizzare voci e locuzioni arcaiche a scapito della lingua viva.
Le polemiche contro la Crusca e l’inattività delle tre accademie fiorentine, (oltre alla Crusca, quella Fiorentina e quella degli Apatisti) contribuirono a determinare la decisione presa nel 1783 da Pietro Leopoldo di accorpare le tre istituzioni in una sola, detta Accademia Fiorentina. In questa occasione il patrimonio della biblioteca e quello dell'archivio della Crusca passarono alla Biblioteca Magliabechiana.
La quinta edizione
L’Accademia della Crusca, come istituzione autonoma, sarà ricostituita nel 1811 con tre scopi prioritari: la revisione del Vocabolario, la conservazione della purità della lingua, l’esame delle opere presentate al concorso letterario indetto tra il 1809 e il 1810.
Nel 1812 furono nominati i nuovi accademici e fu introdotta la distinzione tra accademici residenti e corrispondenti; furono eletti presidente Pietro Ferroni e segretario Lorenzo Collini; nello stesso anno furono presi in esame i progetti, presentati in passato da Rosso Antonio Martini e da Ildefonso Fridiani, per la nuova edizione del Vocabolario.
Il frutto dei lavori preparatori alla nuova edizione, da cui comunque non emergevano segnali di significativi cambiamenti rispetto a quella precedente, fu raccolto nel Prospetto degli oggetti da aversi di mira per la quinta impressione del Vocabolario pubblicato nel 1813.
Una scossa notevole all’impostazione dei criteri da seguire per la nuova edizione fu data dalla Proposta di alcune correzioni ed aggiunte al Vocabolario della Crusca di Vincenzo Monti, il cui primo volume uscì nel 1817: le dure critiche del Monti, che notava la mancanza di voci relative ad arti e scienze, la presenza di molte parole errate, arcaiche o esclusivamente fiorentine, indussero gli accademici a ripensare con maggiore attenzione la tavola degli autori citati.
Nel 1833 furono quattro le commissioni che lavorarono al Vocabolario: una per i termini latini e greci da apporre in corrispondenza alle voci italiane, una per i termini di scienza, una per l’esame e la correzione delle “teoriche grammaticali”, e una per la revisione degli spogli, per le aggiunte e le correzioni. Il metodo di lavoro adottato si dimostrò però estremamente lento, tanto che fra il 1838 e il 1839 intervenne direttamente il Granduca Leopoldo per tentare di sveltire le operazioni: si fissarono due sedute settimanali e si decise di pubblicare il Vocabolario a fascicoli.
Nel 1843 fu pubblicata la prima dispensa e tra il 1844 e il 1851 apparvero soltanto quattro fascicoli; la compilazione della lettera A fu completata nel 1854. Visti i lunghi tempi richiesti dal lavoro, si ripensarono nuovamente i criteri e si stabilì di creare un Glossario in cui far confluire tutte le “parole e locuzioni antiquate, straniere, corrotte e incerte della nostra lingua” e di inserire l’etimologia al in sostituzione delle voci latine e greche.
Il primo volume uscì nel 1863 con dedica a Vittorio Emanuele II e i successivi, con cadenza non sempre regolare, fino al 1923, anno che vide l’interruzione della stampa dell’opera alla lettera O (l’ultima voce registrata è ozono).
Gli accademici avevano lavorato anche alla parte finale del lemmario: e le schede preparatorie delle voci dalla lettera P alla lettera Z, alcune anche molto ricche e già a un buon punto di elaborazione, sono conservate nell’Archivio Storico dell’Accademia.
Approfondimenti
- Claudio Marazzini, Questioni della lingua, in Enciclopedia dell'italiano, treccani.it
- Wolfgang Schweickard, Dizionario, in Enciclopedia dell'Italiano, treccani.it
- Mirko Tavoni, Pietro Bembo, in Encicolpedia dell'Italiano, treccani.it
- La Lessicografia della Crusca in rete: la digitalizzazione completa delle cinque impressioni del Vocabolario
- La banca dati del Fondo dei Citati
- La banca dati della Quinta Crusca Virtuale
I Ritratti